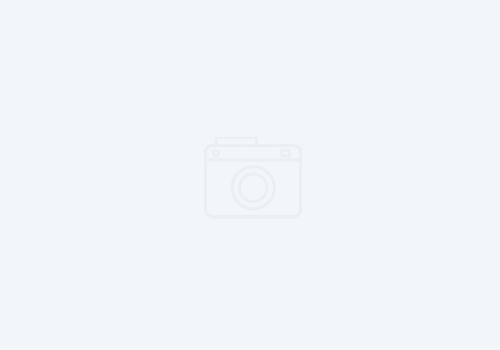Domani si apre il nuovo capitolo di una bella storia
Lavoro per 5 milioni di euro sotto l’egida della Fondazione “Ai Caduti dell’Adamello”
Come sarà ancora non lo sappiamo, sappiamo com’era: bello, silenzioso, quasi… irraggiungibile. Perché, arrivando dal Pian di neve, il Rifugio ai Caduti dell’Adamello era ed è «là». Ma quel «là» era ed è sempre un «là» lontano, perché il ghiacciaio – come il corpo di un vecchio – ogni anno di più si ritira e la vecchia casa di pietra sta sempre più su, lontana, quasi volesse farsi desiderare. Quando venne costruita la caserma alla Lobbia Alta, la neve ed il ghiaccio erano a livello della terrazza, poi… piano, piano, piano la neve ed il ghiaccio hanno presentato il conto alle nefandezze ambientali dell’uomo ritirandosi, anche il rifugio ha rischiato di scivolare a valle. Poi, un giorno, è arrivato un signore che aveva «fatto» la ritirata di Russia (Massimo Mila, raffinato musicologo e accademico del Cai, ben spiegò nei suoi scritti di montagna perché in montagna si dice «fare» il Bianco o «fare» il Basso), prese a cuore il problema del rifugio che non stava più al suo posto, aggregò uomini, istituzioni ed idee ed il progetto del salvataggio decollò. Quel signore dai modi schietti era Sam Quilleri, allora presidente dei Cai di Brescia: fu lui a metter mano alla volontà di non far scivolare a valle la struttura e far andare dispersa la sua storia, fu lui – ingegnere – ad avvertire che la staticità dell’immobile era a rischio e che occorreva intervenire, fu lui ad avviare il dialogo con le istituzioni con un processo durato molti anni, ma ora concluso. Non era facile andare a far cantiere lassù e non era neppure a buon prezzo, e neppure si poteva immaginare che dei volontari intervenissero: poche le settimane dell’anno che avrebbero consentito alle imprese di lavorare in quota, non sempre piene le stagioni di bel tempo, nuvolosità che avrebbe potuto render difficoltoso il volo degli elicotteri per l’approvvigionamento del cantiere e – non ultimi – i costi. Ora al rifugio ristrutturato sarà tolto il velo, l’impianto non sarà ancora agibile, ma avremo la certezza che lo sarà. Lassù è passata la storia: e che storia, dalla «guerra bianca» a Giovanni Paolo II, con dentro tante piccole vicende minori che hanno fatto diventare il rifugio importante quanto come il Cosmique al Bianco, la Capanna Margherita al Rosa, il Duca degli Abruzzi all’Oriondé sul Cervino, porta d’accesso al Carrel e quindi alla vetta. C’era un’appendice del vecchio rifugio straordinaria: la terrazza. Dopo aver «conquistato» la meta di questa casa in quota, dopo aver posato lo zaino e quietata la sete, soprattutto in primavera, quando il ghiacciaio era ancora bianco, anzi quando la luce della primavera lo rende straordinariamente bianco, era (e continuerà ad esserlo) un sogno guadagnare un posto sulla panca, allungare le gambe sulla ringhiera ed al tramonto far correre sogni e pensieri lontano insieme con lo sguardo: laggiù, leggermente sulla destra verso il Corno Bianco, spiare verso Cresta Croce, poi scrutare il vallone del Pian di Neve immaginando chi da quella parte avrebbe potuto arrivare pensando a questi con l’innocuo sadismo di chi la pace del rifugio già l’ha attorno. E non era difficile pensare a chi su quelle nevi aveva vissuto esperienze terribili, sopportato fatiche tremende, provato paure e dire a te stesso «come sono stato fortunato». Sogni che dal prossimo anno si potranno di nuovo godere. Sogni che finivano quando dalla cucina di Martino e Carla Zani (oltre trent’anni di gestione dopo aver lavorato al Garibaldi) giungevano i primi profumi ed il richiamo della tavola (oltre a quello della grande stufa) andava oltre le suggestioni del paesaggio, ben consapevoli che, come i soldati di Cromwell, a pancia vuota il giorno dopo non si sarebbe andati da nessuna parte. E se il cibo era importante, non meno importante era la stufa che Martino alimentava con legna che arrivava quassù da chissà dove; la stufa era una specie di grande mamma di tutti i rifugiati, che asciugava abiti, calze, pelli di foca afrori di piedi e di ascella alimentando una miscela d’odori e di umanità che solamente i rifugi in quota possiedono. Qua e là qualche libro, qualche vecchio settimanale, fogli di quotidiano uscito dallo zaino di qualcuno sparsi e preziosi, perché il giornale in rifugio è come la tavoletta di cioccolato: si spezzetta e si offre a tutti.
Il rifugio era la base sicura (sicura perché se a qualche alpinista succedeva qualcosa Martino non ha mai lasciato nessuno abbandonato a se stesso riportando sempre tutti a casa) per lunghe camminate estive e grandi sci alpinistiche in primavera con Zani che, quando la stagione s’apriva e il rifugio doveva ripartire, doveva usare il badile per conquistare la porta ed in qualche caso addirittura entrare dal tetto. Nevicava, una volta. E nei primi giorni in cui a primavera il rifugio iniziava a lavorare le camere a monte avevano i ghiaccioli alle finestre e non era improbabile che l’acqua gelasse nelle borracce. Domani inizia un’altra storia, dopo che molte altre storie sono nate scritte: importanti (il Santo Padre che vi è salito con il presidente della Repubblica Pertini), allegre, tragiche e impreviste. Non si può non ricordare Claudio Bartoli, giovane e brillante intellettuale cattolico, che un pomeriggio diprimavera del 69 uscì dicendo vado a fare un giro su alla Lobbia e non è più tornato, travolto da una slavina. Lasciò un testamento morale e d’amore per la montagna. Non si possono tacere le fatiche delle grandi risalite a piedi del rifugista per approvvigionare il rifugio e neppure l’ardita teleferica che da Malga Materott risaliva fino al passo della Lobbia. E neppure i fulmini che si infilavano dentro al rifugio: una volta colpendo il lavandino della cucina e disintegrandolo, un’altra forando la tubazione dell’acqua e lasciando tutti a secco. «Chi non c’è stato – racconta Lino Zani, figlio di Martino, guida e maestro di sci – non può capire cosa vuol dire vivere e lavorare cinque mesi lassù». Erano gli anni in cui i giovani andavano (ancora) in montagna, in cui gli svaghi erano semplici e genuini, in cui alla Lobbia Alta s’andava a sciare d’estate, portando gli sci in spalla, poi con uno «skiliftino» sotto l’osservatorio, quindi con il gatto e prendendo lezioni dai «Martino boys». Alla sera nel rifugio si cantava, abitudine che – misteriosamente – è andata dispersa, come disperse sono andate molte buone abitudini, non ultime le buone maniere. Questo è il passato. Il presente è il rifugio che ora sta sotto l’ombrello della Fondazione Ai Caduti dell’Adamello nata nel settembre 2001 che ne ha voluto il recupero (progetto dell’architetto trentino Pallaver) con il consolidamento delle strutture (studio del professor Giuriani dell’Università di Brescia) iniettando nella montagna micropali e tiranti che hanno consentito alla struttura di sostenersi, quindi abbattendo baracche costruite nel tempo (compresa la turbolenta toilette esterna) e ristrutturando l’immobile che dalla primavera tornerà per gli alpinisti. Arredi compresi, tutto costerà circa cinque milioni di euro e potrà ospitare 120 persone. Si apre una nuova pagina.
di Camillo Facchini
GIORNALE DI BRESCIA 9 SETTEMBRE 2005